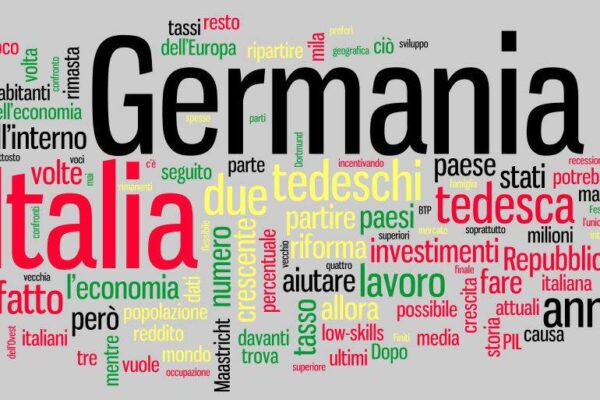EFFETTO COLLATERALE (III)
L’operaismo da Panzieri a Toni Negri una critica marxista di Maria Turchetto* Nell’ambito dell’analisi critica delle posizioni riferibili alla teoria del «lavoro cognitivo» pubblichiamo questo articolo della Turchetto, che è, pur nella sua sintesi, la migliore ricostruzione critica dell’operaismo teorico.e come dalla sua crisi ne